INTORNO AL GIALLO – AUGUSTO BRUNI Il Noir origini e caratteristiche (seconda parte)
AUGUSTO BRUNI
Il Noir
Origini e caratteristiche
(seconda parte)
A proposito di quanto detto sul significato del termine “noir”, faccio alcuni esempi di elementi che “sarebbero” necessari a definirlo:
- Tecniche di ripresa derivate dall'espressionismo tedesco degli anni ‘20 e ‘30, come l'illuminazione fatta di chiaroscuri e di frammenti visivi separati che creano un altro contrasto di immagine fatto di ombre dense, silhouettes, linee oblique e composizioni visive sbilanciate
- tecniche soggettive di narrazione, come la voce fuori campo e il flashback
- uguale enfasi data agli attori e alla costruzione scenografica
Il primo elemento è completamente ingannevole, e si basa sul fatto che molti pretesi film noir sarebbero stati diretti da espatriati europei che venivano dalla Germania, come Edward Dmytryk, Fritz Lang, Robert Siodmak e Billy Wilder, tutti figli in qualche modo dell'espressionismo anni '20 (Il gabinetto del dr. Caligari ne è il manifesto). E di nuovo: cosa hanno in comune una donna muta vittima della cospirazione di uno psicopatico (La scala a chiocciola) e una coppia di assassini per denaro (Double indemnity - La fiamma del peccato)? Nulla, se non il fatto che nel mezzo della trama c’è un assassinio. Ma nel primo caso la protagonista è una vittima incolpevole, nel secondo i due amanti sono assassini che hanno premeditato il loro delitto, e c’è una bella differenza.
Il secondo elemento è anch'esso fuorviante, perché si tratta semplicemente di due modalità narrative che, semmai, esaltano la narrazione come riflessione personale del protagonista, quasi fosse un diario.
Il terzo elemento è anch’esso fuorviante perché al massimo ha un valore significante: la storia si svolge in un ambiente malsano, dove vige la legge del più forte, e visto che nel 99% dei casi siamo in ambito metropolitano, si tratta di una vera giungla d’asfalto. Ma questo elemento può servire nel migliore dei casi a un avvocato per invocare, a difesa del suo cliente, l’attenuante dell’essere nato in un ambiente poco incline alla moralità, come dire: “È l’ambiente, così come le cattive amicizie che hanno determinato in questo caso la personalità del mio cliente: lui di per sé sarebbe un bonaccione, mica un assassino nato.”
Viceversa abbiamo una parte della critica che va abbastanza più vicina a una definizione di Noir sostanziale, perché almeno azzecca quali sono i caratteri veramente importanti dentro una storia Noir:
- I due personaggi principali sono una Femme Fatale o Dark Lady e un Detective alienato e moralmente deragliato, di solito un detective privato, che vive sul filo tra la legge e l'illegalità.
- Una cerchia di comprimari, la maggior parte dei quali sono moralmente ambivalenti e tutti relazionati tra di loro, non importa quale sia lo strato sociale da cui provengono.
- Una narrazione intricata e spesso incoerente creata da motivazioni caratteriali ambigue in cui il detective segue false piste e improvvise svolte narrative
- Uso della voce fuori campo e dei Flashback come discorso del Detective su se stesso
- Ambientazione realistica di ambito metropolitano dal sapore quasi documentaristico
- Perdita di speranza che conduce alla disperazione, all'isolamento e alla paranoia.
La caratteristica più importante di questo tipo di analisi è l'avere individuato il Noir degli anni ‘40 come un dramma metropolitano, in cui i due caratteri principali, Eroe e Antagonista, sono giocati in modo realistico da due tipici borderline. In questo caso il detective non ha quasi più nulla del detective gentiluomo, snob e quasi onnisciente, come potevano esserlo Sherlock Holmes e Poirot. E non ha neanche nulla del detective-burocrate, di solito poco perspicace e talvolta corrotto, che lavora per la forza di polizia pubblica. In compenso questo detective è un solitario, piuttosto misogino, amaro e disilluso nei confronti dell'organizzazione della società. Nei miei termini archetipali potremmo definirlo un Mago  Triste. La sua controparte antagonistica è una donna. Non è un caso che la critica cinematografica e narrativa di stampo femminista abbia individuato nella “femme fatale” o “dark lady” una costruzione narrativa tutta maschile. Di fatto, e in estrema sintesi, questa figura rifletterebbe l’insicurezza di tutto il mondo maschile di fronte a un cambiamento di ruoli sociali che ha cominciato ad avvertirsi in maniera massiccia proprio alla fine della prima guerra mondiale. Questo cambiamento di ruoli è in massima parte determinato dall'entrata massiccia delle donne all'interno del mondo, e questo a sua volta è in massima parte determinato dalla scarsità di uomini, che sono massicciamente impegnati al fronte. Berlino, notoriamente, venne ricostruita dalle donne tedesche. È pur vero che l'entrata delle donne nel mondo del lavoro è cominciata durante la rivoluzione industriale alla metà del XVIII secolo. Ma è anche vero che la loro presenza e importanza, a livello di organizzazione sociale, si è avvertita principalmente dagli inizi del Novecento in poi. Il mancato riconoscimento della parità di diritti dei sessi porta ad una situazione paradossale, nella quale il ricoprire lo stesso ruolo lavorativo non comporta automaticamente un riconoscimento di uguali diritti all'interno della famiglia e della società. Al di là dei movimenti organizzati, come ad esempio quello per il riconoscimento del voto alle donne, esistono risposte individuali a questa disparità. Si rileva un numero sempre crescente di intellettuali donne non sposate e dai comportamenti "trasgressivi". Si afferma in moltissime narrazioni il ruolo dell' avventuriera bella, seducente, irresistibile e fatale. Ma anche questo è un tipico costrutto della paura maschile, ed esso ha radici mitiche antichissime. Pensiamo a Lilith, la prima moglie di Adamo che compare nelle leggende del mondo ebraico eterodosso. Oppure pensiamo alla maga Circe del mito di Odisseo. Entrambe sono legate al mondo animale: la figura della mantide religiosa che dopo la copula con il maschio ne divora la testa oppure l'ape regina dell'alveare che governa tutti i maschi, il cui unico ruolo sociale è quello di fecondatori. Questa paura comincia ad affiorare in maniera impressionante già nel cinema muto di inizi del secolo con Theda Bara (Teodosia Goodman) che nel 1915 interpreta il film "Vampira", la seduttrice che succhia la vita dei suoi amanti, oppure con la Lulù di Louise Brooks, angelica ma rovina famiglie e che finisce uccisa da Jack lo Squartatore, tanto per rassicurare gli uomini; oppure anche con la Marlene Dietrich-LolaLola de l'Angelo Azzurro, rovina dello stimato professor Unrath. Ma siamo sempre al massimo agli anni ‘30!
Triste. La sua controparte antagonistica è una donna. Non è un caso che la critica cinematografica e narrativa di stampo femminista abbia individuato nella “femme fatale” o “dark lady” una costruzione narrativa tutta maschile. Di fatto, e in estrema sintesi, questa figura rifletterebbe l’insicurezza di tutto il mondo maschile di fronte a un cambiamento di ruoli sociali che ha cominciato ad avvertirsi in maniera massiccia proprio alla fine della prima guerra mondiale. Questo cambiamento di ruoli è in massima parte determinato dall'entrata massiccia delle donne all'interno del mondo, e questo a sua volta è in massima parte determinato dalla scarsità di uomini, che sono massicciamente impegnati al fronte. Berlino, notoriamente, venne ricostruita dalle donne tedesche. È pur vero che l'entrata delle donne nel mondo del lavoro è cominciata durante la rivoluzione industriale alla metà del XVIII secolo. Ma è anche vero che la loro presenza e importanza, a livello di organizzazione sociale, si è avvertita principalmente dagli inizi del Novecento in poi. Il mancato riconoscimento della parità di diritti dei sessi porta ad una situazione paradossale, nella quale il ricoprire lo stesso ruolo lavorativo non comporta automaticamente un riconoscimento di uguali diritti all'interno della famiglia e della società. Al di là dei movimenti organizzati, come ad esempio quello per il riconoscimento del voto alle donne, esistono risposte individuali a questa disparità. Si rileva un numero sempre crescente di intellettuali donne non sposate e dai comportamenti "trasgressivi". Si afferma in moltissime narrazioni il ruolo dell' avventuriera bella, seducente, irresistibile e fatale. Ma anche questo è un tipico costrutto della paura maschile, ed esso ha radici mitiche antichissime. Pensiamo a Lilith, la prima moglie di Adamo che compare nelle leggende del mondo ebraico eterodosso. Oppure pensiamo alla maga Circe del mito di Odisseo. Entrambe sono legate al mondo animale: la figura della mantide religiosa che dopo la copula con il maschio ne divora la testa oppure l'ape regina dell'alveare che governa tutti i maschi, il cui unico ruolo sociale è quello di fecondatori. Questa paura comincia ad affiorare in maniera impressionante già nel cinema muto di inizi del secolo con Theda Bara (Teodosia Goodman) che nel 1915 interpreta il film "Vampira", la seduttrice che succhia la vita dei suoi amanti, oppure con la Lulù di Louise Brooks, angelica ma rovina famiglie e che finisce uccisa da Jack lo Squartatore, tanto per rassicurare gli uomini; oppure anche con la Marlene Dietrich-LolaLola de l'Angelo Azzurro, rovina dello stimato professor Unrath. Ma siamo sempre al massimo agli anni ‘30!
Gli uomini tornati a casa dopo la guerra sono per la maggior parte scioccati, deragliati e disoccupati. Le donne prendono il sopravvento nell'organizzazione del lavoro e si fanno strada, anche negli strati più alti della società, attraverso l'appropriazione di ruoli maschili, senza però riuscire ad ottenere un riconoscimento formale di parità. Basti pensare al caso di Amelia Earhart, trasvolatrice oceanica ben più importante di Lindbergh, che nonostante la gloria delle sue imprese viene nominata "Lady Lindy", un soprannome modellato su quello del suo concorrente maschile, cioè Lindbergh stesso.
 Le altre figure femminili negative, testimoni della paura degli uomini, sono le arrampicatrici sociali: sono donne belle, forti, indipendenti e con le idee estremamente chiare in testa. C'è un regista che in modo particolare ha saputo cogliere questa estrema capacità di focalizzazione sull'obiettivo ed è Billy Wilder, il cinico Wilder che alla triade sesso/denaro/potere ha dedicato uno dei suoi film più belli come “La fiamma del peccato” ovvero “Double Indemnity”. E se andate a guardare all'opera della censura nei confronti dei film dove compare una eroina negativa di questo tipo, vedrete che il contrappeso alle sue azioni è sempre un finale drammatico e punitivo riservato alla femmina.
Le altre figure femminili negative, testimoni della paura degli uomini, sono le arrampicatrici sociali: sono donne belle, forti, indipendenti e con le idee estremamente chiare in testa. C'è un regista che in modo particolare ha saputo cogliere questa estrema capacità di focalizzazione sull'obiettivo ed è Billy Wilder, il cinico Wilder che alla triade sesso/denaro/potere ha dedicato uno dei suoi film più belli come “La fiamma del peccato” ovvero “Double Indemnity”. E se andate a guardare all'opera della censura nei confronti dei film dove compare una eroina negativa di questo tipo, vedrete che il contrappeso alle sue azioni è sempre un finale drammatico e punitivo riservato alla femmina.
(continua)


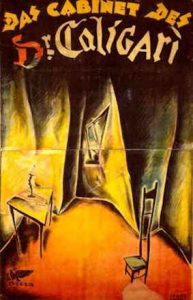





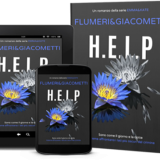

Comments are closed.